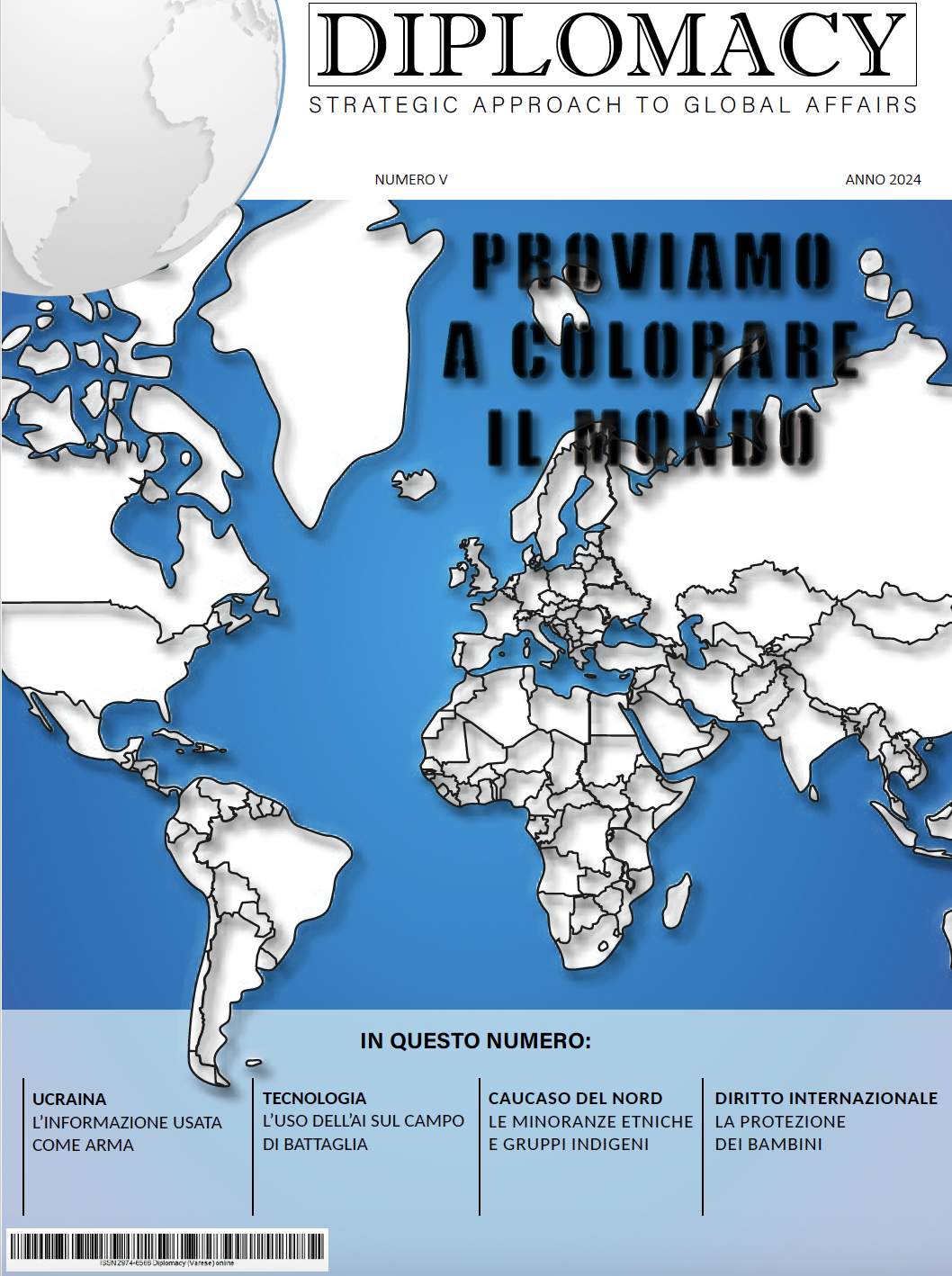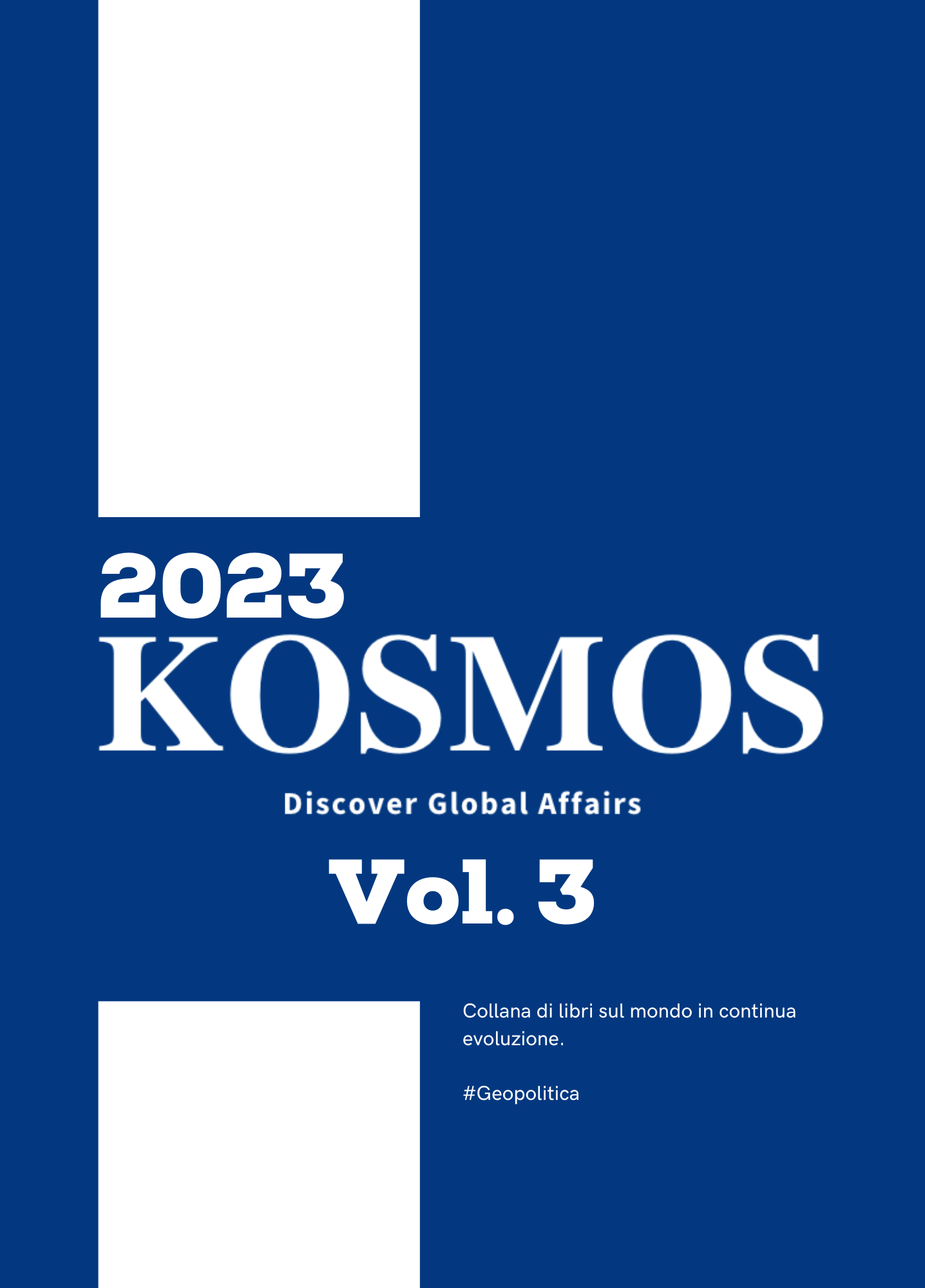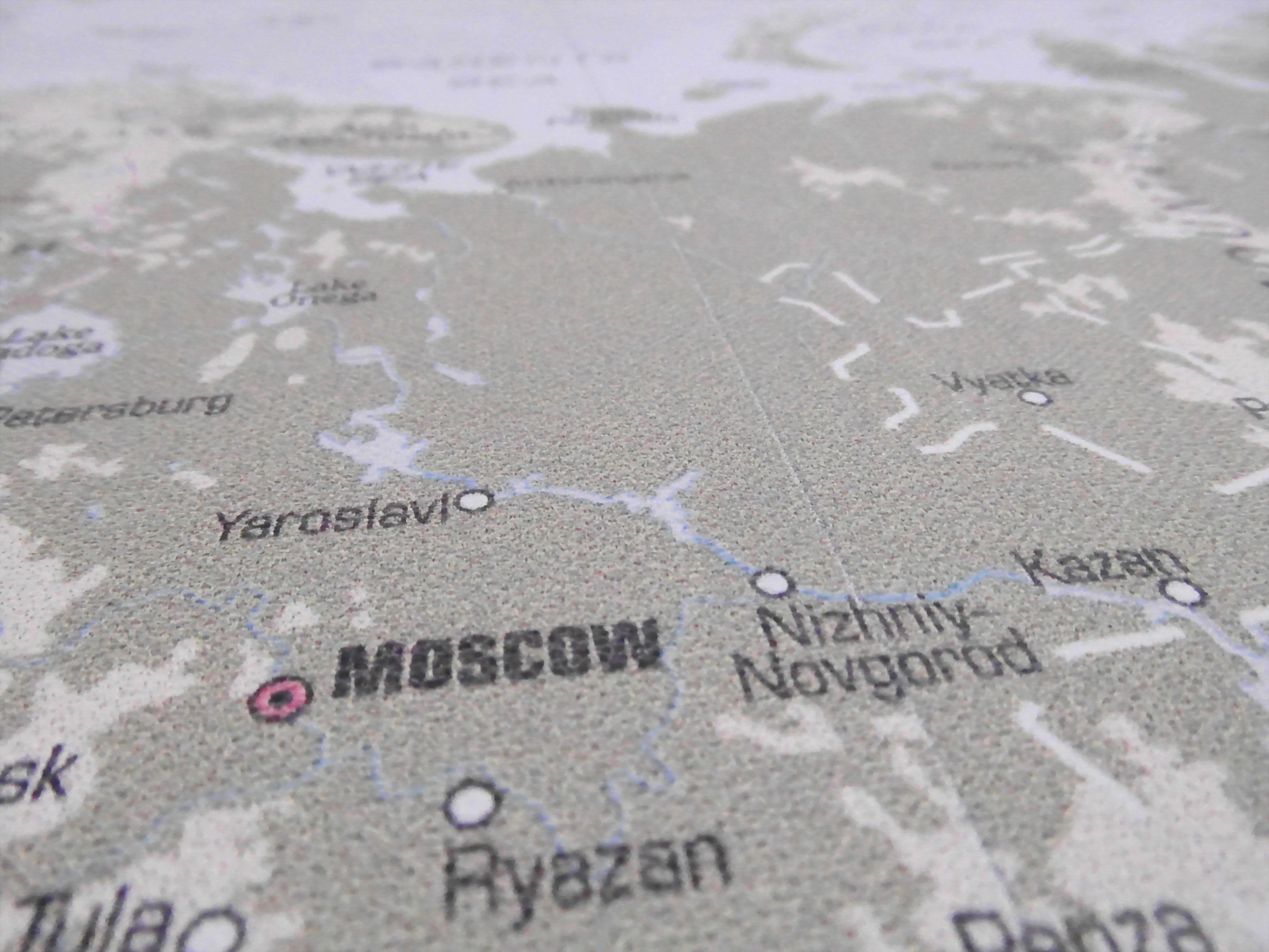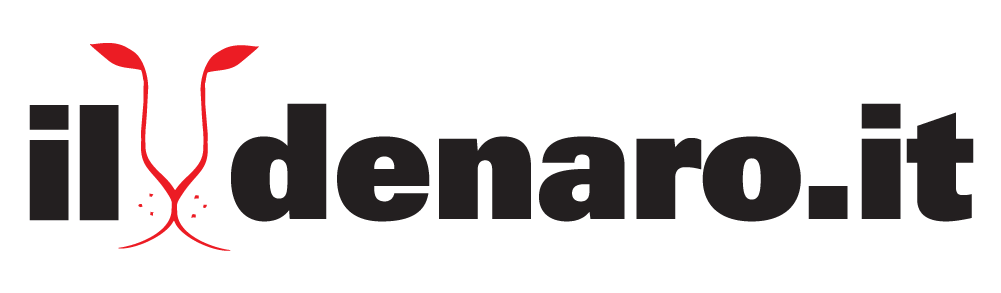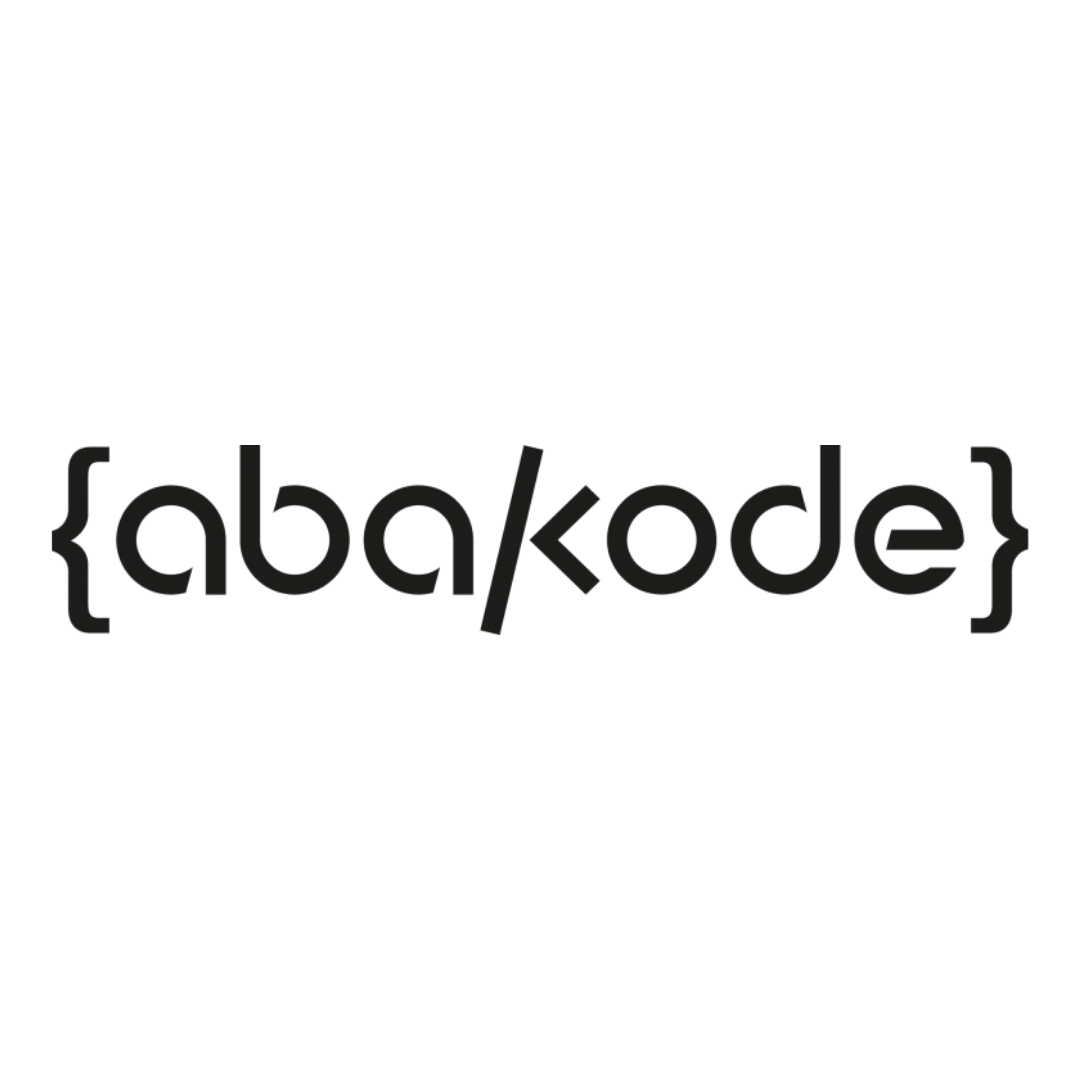25 aprile 2024
L’Etiopia tra conflitti interni e tensioni regionali e la risposta della comunità internazionale
VISUALIZZA25 aprile 2024
Countering terrorism in the Sahel region: an ongoing battle and the new Joint Force between Niger, Mali and Burkina Faso.
VISUALIZZA24 aprile 2024
Il petrolio iracheno varca i confini: l’Iraq si espande nel mercato europeo attraverso la Grecia
VISUALIZZACall for Papers
Diplomacy
Rivista trimestrale di "Affari Internazionali" per conoscere e scoprire i fatti accaduti nel mondo.
Kosmos
Collana di libri "KOSMOS" per approfondire la geopolitica in tutto il mondo. Dall'America del Sud all'Asia, dall'America del Nord all'Australia, passando per Europa ed Africa. Senza dimenticare i poli.
Kosmos
Collana di libri "KOSMOS" per approfondire la geopolitica in tutto il mondo. Dall'America del Sud all'Asia, dall'America del Nord all'Australia, passando per Europa ed Africa. Senza dimenticare i poli.
Growing a New Future
Diplomazia Culturale
Mondo Internazionale opera nell’ambito della diplomazia culturale, promuovendo e svolgendo attività di cooperazione internazionale a carattere interculturale, multiculturale, interdisciplinare ed intergenerazionale.
“Even if we are online, we love Human Connections”
Con un approccio digital driven Mondo Internazionale favorisce lo sviluppo di un dialogo multiculturale in tutto il mondo, a partire dai giovani, inserendoli in una realtà strutturata ed improntata all'innovazione. Le connessioni digitali ed il supporto alle Università, Istituzioni ed Aziende a livello nazionale ed internazionale sono il mezzo fondamentale per lo sviluppo di sinergie globali.
Learning by doing
Le attività promosse da Mondo Internazionale danno la possibilità a tutti gli associati, specialmente ai più giovani, di perseguire una crescita formativa e di sviluppare competenze interdisciplinari ed interculturali tramite un approccio learning by doing in un ambiente strutturato sul modello aziendale che prevede interazioni tra diverse culture e discipline in ambito internazionale.
I giovani hanno la possibilità di sviluppare le proprie competenze nelle cinque aree: le quattro divisioni - Mondo Internazionale Academy, Mondo Internazionale Post, Mondo Internazionale Hub e Mondo Internazionale Geostrategic Earth Observations - G.E.O. e l'area di Amministrazione.
Ciascun individuo è una risorsa fondamentale su cui investire per tracciare una rotta di successo verso lo sviluppo sociale a livello nazionale e globale.